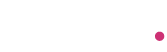Lo chef di origini molfettesi mette al servizio di Adagio Ristorante la sua conoscenza e creatività. Sulla ristorazione barese: “c’è tanta cucina tradizionale, che poi bisognerebbe capire cos’è”.
A 51 anni Antonio Bufi ha le idee chiare su cosa significhi fare lo chef e fare il cuoco. Non è una cosa che si può fare a 24 anni, prima di tutto. Oggi, mentre guida la cucina di Adagio Ristorante, il suo sguardo da anarchico della cucina non è cambiato. Fiammeggia come sempre, spostato e concentrato sulla materia prima e sul restituire con chiarezza quello che c’è nel piatto. La ristorazione barese secondo Bufi? Come il mare d’estate: calma piatta.
Come nasce Antonio Bufi chef?
Intanto nasce a Molfetta. Decido di fare il cuoco perché da piccolo ero sempre in cucina, accanto a mia madre. Partecipavo alla spesa quotidiana e alla preparazione di pranzo e cena. Di là ho deciso di fare il cuoco, frequentando l’alberghiero, fino a diventare chef.
Qual è secondo te la differenza tra l’essere un cuoco e l’essere uno chef?
Il cuoco è una cosa lo chef è un’altra. Si diventa chef perché hai fatto tanta esperienza in giro. Ci sono dei bravissimi cuochi che non sono buoni chef, e bravissimi chef che non sanno cucinare. Lo chef è un leader, è un economo, un meccanico all’occorrenza. Persino uno psicologo. Sanno cucinare, ma è un aspetto relativo, che va in second’ordine rispetto al saper gestire una cucina, gli ordini e la brigata. Ci si arriva con l’esperienza e con il tempo. Io avevo 30 anni, con alle spalle già 15 anni di esperienza. Oggi c’è chi si fa chiamare chef anche se ha 24 anni.
Quindi quando si cercano i “giovani chef con maturata esperienza” si sbaglia.
Certo, è un ossimoro. L’imprenditore cerca una figura “che abbia voglia di crescere insieme”. Invece per avviare un locale si ha bisogno di gente con esperienza, che sa come prendere un’azienda e portarla verso un obiettivo.
Come riassumeresti la tua filosofia di cucina?
Rispetto al passato sono molto più concentrato sulla materia prima e sulla chiarezza di quello che c’è nel piatto. Posso anche creare una preparazione con solo tre ingredienti, purché siano riconoscibili. Sorvolando su tecnica e complicazione delle preparazioni, il piatto deve essere identificabile in tutto, anche nei sapori.
Qual è l’ingrediente a cui sei più legato?
L’anatra, l’ombrina rossa del Gargano e la barbabietola: il resto può girare.
Perché l’anatra?
Mi è sempre piaciuta. È un’alternativa ad altri volatili ed è una cosa che non fa quasi nessuno al contrario del piccione. Che però ha perso i suoi storici destinatari. In passato, anziani, indigenti e puerpere mangiavano il brodo di piccione, tanto che il centro storico barese è pieno di piccionaie atte ad allevarli. Ci vuole molta bravura sia per cucinare l’anatra che il piccione.
E la barbabietola, invece?
È una mia fissa. Ha una consistenza simile alla carne, può sembrare un tonno e ha un sapore un po’ dolciastro. La uso tantissimo e la lavoro in diversi modi.
Infine, l’ombrina del Gargano: cos’è ha di speciale?
Questo pesce mi è stato presentato dallo chef Nazario Biscotti. Ha un sapore erbaceo, stupefacente. Da Adagio la servo con bieta colorata, plancton, cotta alla mugnaia. Ecco, in questa nuova avventura sto riprendendo anche preparazioni classiche come mugnaia e carpaccio, ma da fare in maniera… “aggarbat”.
Quanto conta la tecnica per te?
Sono nato tra la fine della cucina classica, la nouvelle cousine e Ferran Adrià. La mia cucina è un crocevia di queste tecniche. Quando hai perfetta padronanza di una ricetta, dominando la tecnica, sai come ottenere il tuo piatto rimanendo anche all’interno dei limiti di nutraceutica. Perché il cuoco deve pensare prima di tutto alla salute.
Qual è il piatto che ti rappresenta di più?
In generale, il risotto. È una tela sulla quale vai a stratificare ingredienti, mettendo sapori su sapori. Prima c’è lo sguardo, poi l’assaggio e il riconoscimento di ogni elemento. Ma non è detto che ti possa piacere.
Qual è lo chef pugliese che ti ispira?
Ce ne sono due. Salvatore Bufi, che mi ha dato l’imprinting, spingendomi verso la conoscenza della materia prima e la ricerca culturale. A questo, Pippo Todisco ha aggiunto la conoscenza della tecnica, che continuo a utilizzare tutt’oggi.
E tra quelli italiani e stranieri?
Moreno Cedroni. Dopo aver lavorato tanto tempo con lui, mi ha incanalato verso una certa strada. Gualtiero Marchesi mi ha influenzato su tanti aspetti culturali e di pensiero.
Parliamo della ristorazione barese: che momento è?
So cosa c’è in giro e quello che c’è è diverso da quello che facciamo noi da Adagio Ristorante. C’è tanta cucina tradizionale, che poi bisognerebbe anche capire cos’è. Non vedo ricerca. Si vede solo fusion, all you can eat, tanto finto giapponese. È un momento di stasi. Ma più che guardare cosa succede a Bari, mi interessa quello che succede altrove.
Cioè?
Mi piacciono molto Libero Ratti e Antonio Camilli: se dovessi ispirarmi a qualcuno, sceglierei loro due. Senza contare Leonardo d’Ingeo, al quale sono particolarmente legato, appena tornato in Puglia
Perché hai accettato la sfida di Adagio? Cosa ci hai visto?
Il Riva è sempre stato un posto chiave a Bari. È al centro della città e ho sempre pensato che avrebbe potuto fare la differenza. Quando Savino Bartolomeo mi ha chiesto se volessi partecipare a questo progetto di rinascita, ho accettato. Ho deciso che poteva essere l’occasione di tornare a Bari, riprendendo le fila di un discorso interrotto, e iniziarne uno nuovo.
Cosa rispondi a chi dice: “Antonio Bufi da Adagio? E quanto deve durare!”?
Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. Scherzo! So solo che quando la compagine tiene la barra dritta sugli obiettivi che ci si dà, i rapporti possono essere molto duraturi, tenendo fermi schiettezza e attenzione alla qualità.
Riva Club - Ristorante Adagio - Via Fiume 3, Bari. T: 3270855344